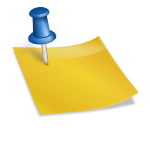Il fenomeno dell’upcycling (“riuso creativo”) viene adottato da numerosi brand di moda al fine di promuovere una moda sostenibile. L’upcycling permette di riutilizzare capi, accessori, borse e tessuti già presenti sul mercato per creare nuovi prodotti percepiti come di maggiore qualità, così limitando gli sprechi e promuovendo la creatività. Tuttavia, la tendenza a modificare o rimettere a nuovo prodotti di marca, per poi venderli senza l’autorizzazione del titolare del marchio o senza informare adeguatamente i consumatori delle modifiche apportate, può dar luogo a complicazioni legali.
Da ciò deriva una importante complicazione per i brand: è possibile promuovere l’upcycling e contemporaneamente proteggere il proprio marchio?
Secondo una recente indagine di Boston Consulting Group, il valore del second hand nel settore della moda e degli accessori di lusso è già pari al 5% delle vendite totali e crescerà fino ad arrivare al 40% nei prossimi anni. Negli ultimi tempi, di fronte all’attenzione mostrata soprattutto dalle Gen Z e Alpha, si sono infatti moltiplicate le iniziative dei brand legate all’upcycling, dando nuova vita ad articoli delle collezioni precedenti e talvolta modificandoli, lanciando siti web dedicati ai propri capi vintage, offrendo agli utenti la possibilità di rivendere i loro e collaborando con le maggiori piattaforme di reselling come Vinted, Vestiaire e Depop per assicurarsi un maggiore controllo sulle vendite. Così, ad esempio, lo scorso anno Valentino ha lanciato il progetto Valentino Vintage, selezionando sette negozi vintage iconici da Seoul a New York in cui i clienti hanno avuto la possibilità di scambiare i propri abiti Valentino in negozio dando loro una seconda vita e il gruppo Richemont ha stipulato un accordo con il marketplace di lusso Farfetch per la rivendita dei propri gioielli.
Se da una parte il fenomeno dell’upcycling è sicuramente in linea con gli impegni di adottare politiche e comportamenti più sostenibili assunti dalle aziende per rendere la moda più sostenibile e ridurre gli sprechi allungando il ciclo vitale dei prodotti, dall’altra l’emergere di questa nuova tendenza ha sollevato importanti questioni legate alla tutela del marchio e ai diritti di proprietà intellettuale dei brand che hanno visto rielaborare da terzi i propri prodotti.
Dopo il caso di Chanel che aveva citato in giudizio negli Stati Uniti una società che realizzava gioielli e accessori con i bottoni presi dai capi di abbigliamento della celebre maison francese, è di questi giorni la notizia che Levi’s ha promosso un contenzioso oltreoceano nei confronti della società Coperni per la presunta violazione del marchio e la vendita di prodotti Levi’s modificati. In particolare, Levi’s contesta sia l’uso da parte di Coperni di linguette in tessuto simili alle proprie sia l’offerta in vendita di prodotti Levi’s “rielaborati” che mantengono l’impuntura registrata Arcuate e il marchio della linguetta di Levi’s, creando un potenziale rischio di confusione tra i consumatori, che potrebbero confondere questi prodotti Coperni con collaborazioni o prodotti con licenza di Levi’s a causa dell’uso non autorizzato del marchio. Controversie analoghe sono state promosse anche da Nike, Rolex e Ralph Lauren e trovano tutte il proprio fondamento nei diritti esclusivi di marchio e nel principio di esaurimento (o “first sale doctrine” nel diritto americano).
Guardando alla normativa nazionale, con la registrazione del marchio vengono riconosciuti in capo al titolare una serie di diritti, tra cui il diritto di utilizzarlo in via esclusiva e di impedirne l’uso a chiunque non sia autorizzato. Tuttavia, in base al principio di esaurimento del marchio, una volta che il titolare mette i beni in commercio non potrà più opporsi ad ulteriori e successive commercializzazioni degli stessi sul mercato. L’art. 5 c.p.i. prevede infatti che “1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo”. Il comma 2 stabilisce però che tale principio non trova applicazione “quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. […]”. In tali casi, infatti, i consumatori potrebbero essere portati a credere che le modifiche apportate al prodotto siano state autorizzate dal titolare del marchio, facendo venir meno la funzione distintiva e di garanzia tipica della privativa in questione.
Per tale motivo alcuni servizi – quali, ad esempio, i servizi di riparazione o di pulizia di un prodotto – non sollevano particolari complicazioni rispetto all’ambito di applicazione del principio di esaurimento, permettendo quindi a un terzo di fornire tali servizi senza bisogno di ottenere l’autorizzazione del titolare del marchio. Diversamente, quando una terza parte interviene sui prodotti recanti il marchio apportandovi una modifica materiale in modo permanente con lo scopo di rivenderli (ad esempio, cambiandone il calore, aggiungendo applicazioni e dettagli o combinando il capo con elementi di altri brand), l’applicazione del principio di esaurimento è da ritenersi esclusa.
La giurisprudenza ha interpretato il concetto di alterazione o modificazione in senso ampio, ricomprendendovi il riconfezionamento, la rietichettatura, e addirittura la rivendita secondo modalità di presentazione pregiudizievoli della notorietà del marchio. In tale prospettiva qualsiasi modifica alle modalità di presentazione del prodotto, ancorché limitata alla confezione o alla immagine complessiva, può in linea di principio essere vietata dal titolare del marchio (Tribunale di Milano, 28 febbraio 2022 e Tribunale di Torino, 12 maggio 2008).
Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, è stato ritenuto responsabile di contraffazione il soggetto che reimmette sul mercato prodotti da lui modificati, mantenendo tuttavia su di essi il marchio originario (Trib. Milano 21 febbraio 1977: “il potere di uso esclusivo del marchio viene leso da chi manipoli il prodotto contrassegnato ad esempio sostituendone la parte esterna originale (nella specie: il rivestimento esterno degli accendisigari), poiché in tale caso egli estende abusivamente la protezione del marchio sulla parte proveniente dalla sua manipolazione ma non prodotta dalla ditta titolare del marchio, unica avente il diritto di servirsi in modo esclusivo del contrassegno”). Nello stesso senso Trib. Milano 19 maggio 1980, secondo cui “costituisce contraffazione di marchio la rivendita con il marchio originario di prodotti manipolati, dovendosi intendere per manipolazione qualsiasi alterazione (sostituzione, aggiunta, eliminazione) volta a modificare le caratteristiche originarie del prodotto e le modalità di presentazione di esso al pubblico”. Sul punto, rileva anche la decisione del Trib. Milano 18 maggio 2004 secondo cui “nell’ipotesi in cui parti di prodotti originali recanti un marchio vengano inserite da un terzo in nuovi prodotti, il terzo non può invocare il principio dell’esaurimento del marchio che riguarda la diversa ipotesi di ulteriore circolazione del prodotto originale sul mercato dopo una prima lecita immissione”.
Nel caso dei prodotti customizzati o comunque rielaborati, il prodotto è nuovo, autonomo e diverso rispetto a quello immesso sul mercato dal titolare del marchio e, di conseguenza, non da lui autorizzato. Con sentenza n. 1459 del 3 ottobre 2018, il Tribunale di Udine si è pronunciato sulla questione per la prima volta anche sotto il profilo penale, ravvisando in questo fenomeno un’ipotesi di contraffazione di marchio altrui ex articolo 473 c.p.. Il caso aveva ad oggetto la produzione e commercializzazione di spille ottenute dall’assemblaggio di bottoni recanti alcuni marchi figurativi e denominativi di un brand di moda. Parte di questi bottoni erano originali, altri contraffatti. Con riguardo alle spille realizzate con i bottoni contraffatti, il Tribunale di Udine ha ritenuto indubbia la sussistenza del reato, ma ha poi precisato che anche l’impiego di prodotti originali (ovvero, nel caso di specie, bottoni) integra l’elemento materiale del reato. Inoltre, è stato confermato che l’assemblaggio del prodotto finale dia luogo a un articolo del tutto nuovo che, sebbene rimanga contraddistinto dal marchio originale, non è stato prodotto o in ogni caso autorizzato dal titolare di quel marchio. Il Tribunale di Udine ha dunque concluso affermando che l’attività di customizzazione è lesiva della fede pubblica (ovvero il bene tutelato dall’art. 473 c.p.), proprio perché il prodotto nuovo recante il marchio originale risulta idoneo ad ingannare i consumatori rispetto all’origine imprenditoriale del prodotto stesso.
Ancor più recentemente, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la contraffazione dei marchi di Airway International Ltd., titolare dei marchi “Dr. Martens” da parte della società resistente che pubblicizzava i celebri stivaletti customizzati attraverso l’aggiunta di borchie, glitter, schizzi di vernice, inserti in tessuto, ecc. e venduti come “modelli unici” a un prezzo superiore rispetto a quello degli articoli originali. Il Tribunale ha ritenuto “che il decreto pronunciato inaudita altera parte debba trovare conferma in quanto, come già osservato in tale sede, non si è verificato l’esaurimento dei diritti di privativa di parte ricorrente sui marchi di cui è titolare, non essendo applicabile tale principio allorché lo stato delle calzature Dr Martens è alterato o modificato dopo l’immissione in commercio da parte di AIRWAIR INTERNATIONAL Ltd (art. 5, co.2 cpi), in assenza dell’autorizzazione di parte ricorrente”. Pertanto, sono stati disposti la descrizione e il sequestro dei prodotti contraffatti e l’inibitoria per la loro produzione, commercializzazione e produzione.
La decisione del tribunale milanese adotta un’interpretazione ancora più ampia del concetto di “alterazione” rispetto alle precedenti e rappresenta sicuramente un risultato importante per la tutela dei brand interessati da questa tendenza, aprendo la strada a nuovi contenziosi. Tuttavia, nello scenario attuale caratterizzato da una sempre maggior attenzione per le tematiche ESG, il fenomeno dell’upcycling impone un bilanciamento tra l’interesse pubblico ad un’economia circolare volta a ridurre gli sprechi e prolungare il ciclo vitale dei prodotti di moda (tradizionalmente destinati ad un consumo poco responsabile) e l’interesse individuale del titolare del marchio a cui sono attribuiti diritti esclusivi. L’instaurazione di un contenzioso su questi temi richiede dunque alle aziende una riflessione più ampia per assicurarsi di non intraprendere azioni che possano essere in contrasto con i propri impegni e campagne in tema di impegno sostenibile ed evitare dunque in ultima istanza un danno d’immagine. Anche per questo motivo, una possibile soluzione già adottata da alcuni brand è quella di lanciare essi stessi l’upcycling dei propri prodotti, in modo da avere il pieno controllo sulla loro trasformazione ed evitare che siano poi terzi a farlo.
Su un argomento simile si veda l’articolo “Come i fashion brand possono promuovere la sostenibilità e proteggere il loro marchio“.