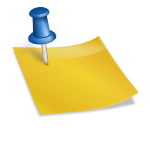Il 20 marzo 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale (“DDL AI“), il provvedimento finalizzato ad armonizzare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act“), per chiarire il contesto evolutivo dell’intelligenza artificiale (“AI“) in Italia.
Il DDL AI, come l’AI Act, pone al suo centro lo sviluppo e l’utilizzo trasparente, responsabile e conforme ai diritti fondamentali dei sistemi di AI nei differenti settori della società, puntando a definire la base per lo sviluppo di una strategia nazionale in ambito AI al fine di accrescere la competitività strategica del Paese.
Vengono introdotte specifiche disposizioni volte a regolare l’utilizzo trasparente e sicuro dell’AI nei seguenti settori:
- sanitario e ricerca scientifica;
- mondo del lavoro e professioni intellettuali;
- attività giudiziaria;
- pubblica amministrazione;
- sicurezza nazionale;
Di seguito si riportano le previsioni più rilevanti del DDL AI per settore.
Utilizzo dell’AI nei settori critici
Ambito Sanitario
Il DDL AI riconosce il potenziale dell’intelligenza artificiale nel settore medico, ma al contempo ne disciplina l’impiego per garantire un utilizzo etico e sicuro. A tal fine, stabilisce alcune regole fondamentali, tra cui il divieto di utilizzo dei sistemi di AI al fine di selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie; l’obbligo di informare il paziente circa l’utilizzo di tecnologie di AI e di misurare la performance al fine di minimizzare il rischio di errori.
In ogni caso, il DDL AI prevede che i sistemi di AI debbano essere utilizzati quali mero supporto all’attività di prevenzione, diagnosi e cura prestata dagli esercenti la professione medica. La responsabilità per la decisione finale rimane dunque esclusivamente in capo al medico, che dovrà sempre monitorare il corretto funzionamento dell’AI e verificare gli output generati.
Ricerca scientifica
L’art. 8 del DDL AI prevede che le attività di ricerca volta alla realizzazione di sistemi di AI, qualora svolte da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), siano dichiarati di rilevante interesse pubblico. Come tali, queste ricerche potranno beneficiare del trattamento di dati personali anche in assenza del consenso degli interessati, secondo le condizioni previste dall’art. 9 GDPR e 110 del Codice Privacy italiano. Tuttavia, la liceità di ogni trattamento resta subordinata all’approvazione dei comitati etici competenti e alla preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Ambito lavorativo
L’art. 11 del DDL AI sottolinea l’importanza del rispetto della dignità umana, della trasparenza e del divieto di discriminazione nell’impiego dell’AI nel settore del lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa già in vigore. In particolare, il DDL specifica l’obbligo di informare adeguatamente i lavoratori sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, ponendosi in continuità con la normativa privacy e giuslavoristica e in particolare con le disposizioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori, che richiedono l’attivazione di meccanismi di salvaguardia previsti dallo Statuto dei Lavoratori.
Infine, per garantire un monitoraggio continuo dell’impatto dell’AI sul mondo del lavoro, viene istituito l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di sviluppare strategie di regolamentazione, valutare gli effetti dell’AI sul mercato del lavoro e identificare i settori più coinvolti da questa trasformazione tecnologica.
Professioni intellettuali
Come già previsto per le professioni mediche, l’art. 13 del DDL AI prevede che i sistemi di AI possano essere impiegati esclusivamente come strumenti di supporto all’attività professionale, senza mai sostituire il contributo intellettuale del professionista. Di conseguenza, il professionista non potrà affidare integralmente l’erogazione della propria prestazione intellettuale a un sistema di AI, anche nel caso in cui il destinatario del servizio presti il proprio consenso. Tale previsione solleva alcune criticità applicative, a causa della difficile distinzione tra un utilizzo meramente ausiliario dell’AI e un impiego prevalente rispetto all’apporto umano.
Il DDL AI prevede poi che il professionista sia sempre tenuto a informare il destinatario della prestazione in modo chiaro, semplice ed esaustivo sull’impiego di sistemi di AI. Sebbene la norma faccia riferimento esclusivamente alle informazioni relative alla tecnologia utilizzata, l’obbligo introdotto risulta eccedente rispetto a quanto previsto dall’AI Act, che non prevede limitazioni per i sistemi di AI non ad alto rischio. Inoltre, il DDL AI non specifica quali siano le conseguenze sul piano contrattuale nel caso in cui un professionista utilizzi sistemi di AI senza dichiararlo preventivamente.
Giustizia e pubblica amministrazione
Gli articoli 14 e 15 del DDL AI regolano l’uso dell’AI nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria. In entrambi gli ambiti si sottolineano due aspetti fondamentali:
- L’AI deve avere esclusivamente un ruolo di supporto, senza sostituire la valutazione e la decisione dell’operatore umano;
- La pubblica amministrazione si impegna a promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze digitali dei professionisti del settore, affinché possano utilizzare l’AI in modo consapevole e responsabile.
È inoltre importante rilevare che, già all’art. 6 dedicato alla strategia per l’intelligenza artificiale, il DDL AI introduce una specifica disposizione per l’utilizzo dell’AI da parte delle pubbliche amministrazioni, per garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. Tale disposizione prevede infatti che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.
Individuazione delle autorità competenti
Confermando quanto già previsto nella prima bozza, il DDL AI individua quali autorità nazionali competenti per l’AI, anche ai sensi dell’AI Act:
- l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), che acquisirà il ruolo di autorità di notifica con funzioni di accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale. L’AgID sarà inoltre responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
- e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN): individuata come autorità di vigilanza, oltre che autorità guida per l’uso dell’AI per la cybersicurezza. Nella gestione pubblica dell’AI, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS mantengono un ruolo di vigilanza settoriale per l’ambito creditizio, finanziario e assicurativo.
L’individuazione di AgID e ACN, in quanto autorità governative, sembra trascurare quanto segnalato dalla Commissione europea nel parere (C(2024) 7814), dove si ricordava che le autorità devono possedere lo stesso livello di indipendenza previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 per le autorità preposte alla protezione dei dati nelle attività delle forze dell’ordine, nella gestione delle migrazioni e controllo delle frontiere, nell’amministrazione della giustizia e nei processi democratici.
AI e diritto d’autore
All’art. 25, il DDL AI regola la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, chiarendo che anche queste sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore. In linea con quanto già previsto dagli artt. 70-ter e 70-quater della Legge sul diritto d’autore, viene inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi.
È stata invece soppressa, in allineamento con quanto segnalato nel parere circostanziato della Commissione europea, la previsione secondo cui i contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale avrebbero dovuto essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l’acronimo “IA”. Tale norma, infatti, era eccedente rispetto agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafi 2 e 4 dell’AI Act.
Modifiche al Codice civile e penale
Il DDL AI, all’art. 17, interviene con una modifica all’art. 9 del Codice di procedura civile per attribuire all’esclusiva competenza del tribunale ordinario “le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale“, impedendo così l’avvio di contenziosi relativi all’utilizzo dell’AI, anche se di modico valore, davanti al giudice di pace.
Infine, l’art. 26, dedicato alla tutela penale, stabilisce una nuova circostanza aggravante legata all’uso dell’AI, in base alla quale la commissione di un reato potrebbe comportare pene più severe quando questa ha coinvolto “l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato“. Se l’utilizzo dell’AI è legato alla commissione reati contro i diritti politici del cittadino (Art. 294 c.p.), la pena alla reclusione viene aumentata, raggiungendo da un minimo di 2 fino a un massimo di 6 anni. Inoltre, il DDL AI introduce una nuova fattispecie di reato, finalizzato a punire la condivisione di deepfake senza il consenso della persona ritratta, quando la condivisione cagioni a quest’ultimo un danno ingiusto.
Conclusioni
Il testo approvato dal Senato passa ora all’esame della Camera dei deputati. Una volta raggiunto un accordo sul testo definitivo, la normativa italiana sull’intelligenza artificiale dovrà comunque essere completata dall’intervento del Governo, a cui il DDL AI delega la redazione di “uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale” (art. 16).
Secondo l’art. 24 del DDL AI, il Governo è inoltre delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act, che dovranno includere la definizione dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori di ACN e AgID, oltre a misure per l’aggiornamento della normativa vigente in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento. La delega legislativa comprende anche la definizione di regole in materia di responsabilità civile per i danni derivati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
La copertura solo parziale dei settori impattati dall’AI, oltre alla persistente incompatibilità di alcune delle disposizioni rispetto alla normativa europea, rende l’approvazione del DDL AI un traguardo mancato. A quasi 8 mesi dall’entrata in vigore dell’AI Act, la strategia italiana sull’intelligenza artificiale resta ancora poco chiara. Se il vaglio del testo da parte della Camera richiederà ancora qualche mese, bisognerà attendere molto più a lungo per arrivare all’approvazione dei decreti legislativi di iniziativa governativa, che dovrebbero portare finalmente alla definizione di un panorama più chiaro e definito sull’AI.
Per ulteriori informazioni sulle questioni legali relative all’intelligenza artificiale, consigliamo di leggere la nostra rivista giuridica sull’AI, le cui ultime edizioni sono disponibili QUI.
Su un simile argomento può essere d’interesse l’articolo “AI e copyright – US Fair Use vs EU TDM dopo la decisione del Delaware”
Autori: Marianna Riedo e Federico Toscani