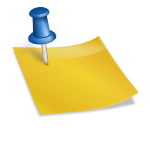Man mano che le stablecoin si evolvono da strumenti speculativi a pilastri dell’infrastruttura finanziaria sono sempre più coinvolte nel fuoco incrociato tra filosofie normative e geopolitica monetaria. In questo panorama in evoluzione, gli Stati Uniti e l’Unione Europea offrono due risposte nettamente divergenti.
Il Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (di seguito, “Genius Act”), firmato il 18 luglio 2025 dal Presidente degli Stati Uniti d’America (“USA”), sancisce un approccio di deregolamentazione che incoraggia l’innovazione privata basata sul dollaro su scala globale, una visione che il Parlamento europeo ha provocatoriamente etichettato come “criptomercantilismo”.
Al contrario, il regolamento 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (“MiCAR”) dell’Unione europea (“UE”) segna un’affermazione difensiva ma strategica della sovranità monetaria, inserendo le attività digitali in un quadro di vincoli, anche afferenti al diritto pubblico, soglie di vigilanza e controllo da parte della banca centrale.
Basandosi sullo studio del Parlamento europeo EP760.274/2025 (lo “Studio del PE”) e su una serie di analisi transatlantiche, il presente articolo confronta le architetture normative del Genius Act e di MiCAR, il loro trattamento degli emittenti di stablecoin, i regimi di riserva, i poteri di vigilanza e, in ultima analisi, le loro visioni opposte sulla moneta digitale.
- Criptomercantilismo: l’offensiva digitale del dollaro
Nella nuova architettura della finanza digitale, la sovranità monetaria dipende sempre più dalla capacità degli Stati di plasmare, o resistere, alle infrastrutture monetarie transfrontaliere. Gli USA hanno adottato una strategia assertiva nota come “criptomercantilismo”, un termine coniato dal Parlamento europeo per descrivere la promozione delle stablecoin sostenute dal dollaro come strumenti di espansione geopolitica.
Evocando il mercantilismo classico, in cui il potere derivava dall’esportazione e dall’accumulo di riserve, il suo analogo digitale sostituisce le merci con token ancorati al dollaro integrati nelle reti di pagamento globali. Il Presidente Trump sta incoraggiando apertamente lo sviluppo di stablecoin sostenute dal dollaro in tutto il mondo, presentandole come strumenti per rafforzare il dominio del dollaro. I funzionari del Tesoro hanno confermato che queste monete contribuirebbero a preservare il ruolo del dollaro come valuta di riserva mondiale.
Questa strategia ha due obiettivi.
- In primo luogo, integrare il dollaro nelle economie digitali emergenti, in particolare nelle regioni con infrastrutture bancarie deboli, dove le società di criptovalute con sede negli Stati Uniti promuovono le stablecoin come strumenti di inclusione.
- In secondo luogo, generare domanda di debito statunitense: richiedendo che le stablecoin siano garantite da attività in dollari a basso rischio, in particolare titoli del Tesoro, il criptomercantilismo trasforma l’emissione privata in una leva finanziaria pubblica.
Il Genius Act istituzionalizza questa visione. Prevede un regime di licenze permissivo sia per le banche che per gli istituti non bancari, consente di detenere riserve in un’ampia gamma di attività denominate in dollari e non impone restrizioni territoriali, consentendo così la circolazione globale. I giganti tecnologici statunitensi favoriscono ulteriormente questa diffusione integrando i pagamenti in stablecoin nei loro ecosistemi, offrendo incentivi come cashback e punti fedeltà.
Per l’UE, ciò rappresenta una sfida esistenziale. Come avvertito dallo studio del PE, il rischio non risiede solo nella disintermediazione interna, ma anche nell’erosione del ruolo internazionale dell’euro e nell’indebolimento della governance monetaria dell’UE. In quest’ottica, MiCAR non è solo una regolamentazione finanziaria: è un atto di autodifesa monetaria.
- MiCAR vs Genius Act: architetture divergenti della moneta digitale
L’UE e gli Stati Uniti hanno risposto all’ascesa delle stablecoin con due modelli normativi fondamentalmente diversi.
- MiCAR, in vigore da luglio 2024, adotta una logica di diritto pubblico: mira a contenere i rischi sistemici, preservare la sovranità monetaria ed integrare le stablecoin in un ecosistema finanziario strettamente supervisionato.
- Il Genius Act, in vigore da pochi giorni, riflette una filosofia di deregolamentazione: incoraggia l’innovazione monetaria privata e rafforza il dominio globale del dollaro.
Come evidenziato nell’allegato I dello studio del Parlamento europeo, i due quadri normativi divergono su sette aspetti fondamentali:
- Ammissibilità degli emittenti: MiCAR limita l’emissione agli istituti di credito o agli istituti di moneta elettronica, mentre il Genius Act apre il mercato a soggetti non bancari autorizzati dallo Stato o dalle autorità federali, compresi i giganti della centralizzazione tecnologica.
- Rimborso: entrambi prevedono un rimborso in valuta fiat 1:1. Tuttavia, il MiCAR consente l’intervento delle autorità di vigilanza (ad esempio, i redemption gate), mentre il Genius Act si affida a meccanismi post-fallimento come la priorità in caso di fallimento.
- Designazione sistemica: il MiCAR identifica gli emittenti “significativi” e li sottopone a obblighi più severi. Il Genius Act applica un approccio unico per tutti, ignorando la stratificazione del rischio sistemico.
- Riserve: il MiCAR richiede riserve di alta qualità ed a basso rischio con regole di custodia rigorose. Il Genius Act consente tipi di attività più ampi, aumentando la flessibilità ma aumentando l’esposizione a shock di liquidità o di credito.
- Vigilanza: il MiCAR centralizza la vigilanza tramite l’Autorità Bancaria Europea (“ABE”) e le autorità nazionali. Il Genius Act frammenta la vigilanza tra attori statali e federali, con un’applicazione proattiva limitata.
- Extraterritorialità: il MiCAR vieta le stablecoin di paesi terzi a meno che non siano autorizzate nell’UE. Il Genius Act promuove l’equivalenza transfrontaliera e l’esportazione delle norme, rafforzando la portata del dollaro.
- Garanzie monetarie: il MiCAR conferisce alla Banca centrale europea (“BCE”) il potere di limitare i token non in euro che minacciano l’area dell’euro. Il Genius Act non contiene tali garanzie e sostiene implicitamente la dollarizzazione globale.
Queste differenze non sono solo tecniche. Esse riflettono visioni opposte: una cerca di contenere l’influenza della moneta digitale privata, l’altra di proiettarla a livello globale. Il MiCAR è un modello di contenimento normativo. Il Genius Act è un progetto di espansione monetaria.
- Rischi sistemici e firewall monetario europeo
Le stablecoin sostenute dal dollaro non solo mettono in discussione i quadri normativi, ma minacciano piuttosto di erodere la sovranità monetaria oltre i confini degli Stati Uniti. Come sottolineato dallo studio del PE del 2025, questi rischi riguardano sia la fragilità finanziaria interna che lo spostamento monetario esterno.
- Vulnerabilità interne
Anche se completamente garantite, le stablecoin rimangono vulnerabili alle tensioni del mercato. Riserve illiquide o opache possono innescare corse speculative, mentre le promesse di rimborso possono crollare sotto pressione, come hanno dimostrato i precedenti episodi di sganciamento di Tether e Circle. Inoltre, la riallocazione delle riserve alla ricerca di rendimenti, in particolare dall’UE verso gli Stati Uniti, potrebbe alimentare il contagio finanziario e compromettere la trasmissione monetaria all’interno dell’eurozona. Con il trasferimento dei fondi degli utenti verso stablecoin non bancarie, le banche tradizionali potrebbero trovarsi ad affrontare vincoli di liquidità, compromettendo la loro capacità di prestito.
- Dollarizzazione transfrontaliera
L’uso diffuso di stablecoin ancorate al dollaro statunitense all’interno dell’UE potrebbe portare a una dollarizzazione digitale di fatto. Ciò esporrebbe gli utenti alla volatilità dei tassi di cambio, limiterebbe l’autonomia politica della BCE e indebolirebbe il ruolo internazionale dell’euro. Inoltre, gli emittenti non autorizzati di paesi terzi creano lacune nell’applicazione delle norme e aprono la porta a vulnerabilità in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, soprattutto in assenza di un allineamento normativo a livello globale.
- La risposta del MiCAR: difesa monetaria preventiva
Il MiCAR affronta queste minacce attraverso un doppio meccanismo di salvaguardia:
- Soglie quantitative, ai sensi degli articoli 23 e 58: volumi giornalieri superiori a 1 milione di transazioni o 200 milioni di euro determinano l’intervento di vigilanza.
- Potere discrezionale della BCE, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3: indipendentemente dai parametri, la BCE può vietare l’emissione di token ancorati a valute estere che minacciano la stabilità monetaria.
In quest’ottica, il MiCAR va oltre la vigilanza prudenziale. Agisce come un firewall monetario, preservando l’integrità dell’euro in un mondo digitalizzato e dollarizzato.
- Dalla difesa normativa alla sovranità monetaria digitale
Di fronte all’ambizione extraterritoriale del Genius Act, la risposta dell’UE va ben oltre il MiCAR. Essa riflette una strategia più ampia volta a riaffermare la sovranità monetaria digitale, non imitando modelli di deregolamentazione, ma combinando innovazione monetaria pubblica, coerenza normativa e leadership multilaterale.
- L’euro digitale come ancora di sovranità
Al centro c’è l’euro digitale: una moneta emessa dalla banca centrale progettata per preservare il denaro pubblico di fronte alle alternative private basate sul dollaro. A differenza delle stablecoin, è una passività della banca centrale priva di rischio, integrata in un sistema di controllo democratico e in un’infrastruttura che tutela la privacy. Fondamentalmente, il suo obiettivo non è quello di competere a livello globale, ma di garantire la resilienza monetaria interna, fungendo da “ancora monetaria”, come descritto dal membro del consiglio direttivo della BCE Fabio Panetta.
L’integrazione con l’infrastruttura europea dei servizi blockchain (“EBSI“) rafforza ulteriormente l’autonomia, promuovendo un’architettura digitale sovrana slegata dalle piattaforme dominate dagli Stati Uniti.
- Gli standard normativi come leva strategica
L’UE ha sempre rifiutato di abbassare i propri standard per attirare gli emittenti di stablecoin. MiCAR respinge le scorciatoie concesse ai paesi terzi in materia di licenze e sancisce soglie di conformità elevate. Questa posizione non è difensiva, ma deliberata: afferma che gli standard normativi sono vettori di sovranità, che consentono all’UE di plasmare le norme globali anziché seguirle.
- Multilateralismo anziché concorrenza normativa
Infine, l’UE promuove il proprio modello attraverso forum internazionali quali l’FSB e l’IOSCO. Pur essendo aperta all’equivalenza, la subordina a una convergenza sostanziale, in particolare per quanto riguarda la copertura delle riserve, i diritti di rimborso ed i poteri di vigilanza. Questa strategia multilaterale è in linea con il più ampio orientamento dell’UE verso l’autonomia strategica: dal liberalismo di mercato alla regolamentazione basata su principi.
Nel settore delle stablecoin, come in quello dell’IA o della governance dei dati, l’ambizione dell’UE è chiara: definire le regole della sovranità digitale non in base alla scala, ma alla struttura.
- Genialità o arroganza? Ridefiniamo il divario normativo
Sebbene spesso descritti come risposte parallele a una sfida comune, MiCAR ed il Genius Act incarnano due visioni fondamentalmente opposte del futuro della moneta. Il Genius Act, nel nome e nella struttura, riflette una forma di arroganza normativa: presuppone che gli attori privati possano emettere in modo sicuro moneta denominata in dollari su scala globale con una supervisione minima, trasformando le stablecoin in strumenti di mercantilismo digitale e di leva geopolitica.
MiCAR, al contrario, non è un semplice statuto finanziario, ma una costituzione monetaria. Afferma che il denaro è un’infrastruttura pubblica, che deve rimanere integrata nei quadri giuridici, istituzionali e democratici. In questa visione, l’innovazione è benvenuta, ma solo quando rispetta la logica dell’ordine monetario ed il primato del diritto sovrano sul codice privato.
Questa divergenza riflette più di una semplice filosofia normativa. Rivela una frattura geopolitica: tra l’egemonia del dollaro e la sovranità digitale europea, tra reti governate da incentivi di mercato e sistemi governati dall’autorità pubblica. La regolamentazione delle stablecoin non è quindi più una questione tecnica, ma una questione costituzionale per l’era digitale.
Opponendosi alla deriva deregolamentatrice del Genius Act, l’Europa manifesta la sua ambizione di proporre un modello alternativo di finanza digitale, che privilegi la sovranità rispetto alla scala, il diritto rispetto al codice e la stabilità pubblica rispetto all’espansione privata. Non è ancora chiaro se questa visione prevarrà. Ma nella contesa per il futuro del denaro, il genio da solo non basta. Ciò che conta è essere sovrani e conoscere esattamente cosa ciò comporti.
Autori: Andrea Pantaleo e Giulio Napolitano