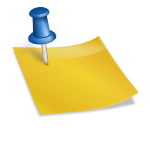L’8 agosto 2025 sono entrate ufficialmente in vigore le disposizioni cruciali del Regolamento (UE) 2024/1083 per un quadro comune sui servizi di Media (di seguito, “Media Freedom Act” o “MFA”), modificante la Direttiva 2010/13/UE (di seguito, “Direttiva SMAV”), che definisce a livello unionale standard minimi e vincolanti a tutela dell’indipendenza editoriale, della trasparenza proprietaria e della protezione delle fonti giornalistiche.
Il nuovo quadro normativo non opera isolatamente ma si innesta in sinergica armonia al Regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito, “Digital Services Act” o “DSA”), integrandone le garanzie generali in materia di moderazione dei contenuti con un regime speciale destinato ai fornitori di servizi di media (di seguito, “Media Service Providers” o “MSPs”).
Cuore pulsante di questa sinergia è l’Articolo 18 MFA, che introduce un procedimento rafforzato per le piattaforme online di dimensioni molto grandi (di seguito, “VLOPs”) ai sensi dell’Articolo 33, paragrafi 1 e 4, DSA, imponendo nuovi obblighi procedurali qualora si intenda rimuovere o limitare contenuti pubblicati da prestatori di servizi di media riconosciuti come indipendenti e responsabili.
Si tratta di un passaggio che segna l’ultima tappa della ventennale evoluzione del regime di responsabilità degli Internet Service Providers (di seguito, “ISP”) e, in generale, dei fornitori di servizi di intermediazione online.
Il viaggio comincia dalla “Good Samaritan clause“, contenuta nella Sezione 230 del Communications Decency Act statunitense del 1996, che garantiva ampie immunità agli ISP passivi nella moderazione dei contenuti sulla propria piattaforma. In Europa, il modello si è radicalizzato nel “notice and take down“ della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (di seguito, “Direttiva eCommerce”) che imponeva agli hosting provider di rimuovere i contenuti illeciti “senza indugio” dopo averne avuto conoscenza effettiva. Di recente, il DSA, indiscusso erede della Direttiva eCommerce, ha introdotto il “notice and action” ai sensi dell’Articolo 16, spostando il baricentro dalla mera rimozione di contenuti alla cooperazione preventiva. Con il MFA, si compie un ulteriore passo avanti ed il diritto unionale impone un obbligo giuridico di dialogo strutturato tra piattaforma, media ed autorità competenti – che potremmo definire “notice and comment”.
1. Retroscena normativo-regolamentare del Media Freedom Act
Il MFA si inserisce nel quadro dell’European Democracy Action Plan (di seguito, “EDAP”), adottato dalla Commissione europea nel Novembre 2020 per rafforzare la resilienza democratica dell’Unione.
L’EDAP si articola in tre pilastri strategici:
- Elezioni libere e corrette: attuato, tra l’altro, con il Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza della pubblicità politica, che impone obblighi di tracciabilità e informazione sugli inserzionisti e sui criteri di targeting.
- Contrasto alla disinformazione: irrobustito dal Codice di condotta sulla disinformazione, strumento di coregolamentazione con le piattaforme online risalente al Febbraio 2025, e dalle norme del DSA.
- Libertà e pluralismo dei media: di cui il MFA ne rappresenta il baluardo insieme alla Direttiva (UE) 2024/1069 contro le azioni legali vessatorie (“Strategic Lawsuits Against Public Participation” o “SLAPPs”), adottata per proteggere giornalisti e attivisti da procedimenti giudiziari abusivi.
La proposta di regolamento, presentata il 16 settembre 2022, si fonda sull’articolo 114 TFUE per armonizzare le normative nazionali in materia di media, assicurando il corretto funzionamento del mercato interno anche attraverso la protezione di un bene essenziale come la libera informazione.
Dopo un complesso negoziato politico il testo è stato approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024, dal Consiglio il 26 Marzo 2024 ed è entrato formalmente in vigore, attraverso una progressiva implementazione, a partire dall’8 Novembre 2024.
2. Lo scheletro del Media Freedom Act
Il Media Freedom Act si articola in quattro Capi e ventinove articoli e disegna un’architettura normativa a geometria variabile, imponendo obblighi tanto orizzontalmente nei rapporti tra media e piattaforme online quanto verticalmente agli stati membri.
- Il Capo I definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento (cfr. Art. 1), fissando le definizioni chiave (cfr. Art. 2). Includendo riferimenti puntuali ad altri atti UE – dal Regolamento (UE) 2019/1150 (di seguito, il “Regolamento P2B”).al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), fino al DSA e al Regolamento (UE) 2022/1925 (“DMA”) – è facile evincere un ossequio al principio di non pregiudizio: il MFA non sostituisce le tutele generali previste per l’ecosistema digitale, bensì le integra con misure mirate alla salvaguardia del pluralismo e dell’indipendenza editoriale.
- Il Capo II (cfr. Artt. 3-6) codifica diritti e doveri di fruitori e fornitori di servizi di media: il diritto del pubblico ad accedere a una pluralità di contenuti editorialmente indipendenti; la protezione rafforzata delle fonti e delle comunicazioni riservate; il divieto di spyware salvo eccezioni tassative, con autorizzazione giudiziaria e controllo di proporzionalità ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680; l’obbligo per i servizi pubblici radiotelevisivi di essere indipendenti nelle nomine e nel finanziamento; la trasparenza proprietaria e sui fondi pubblici ricevuti.
- Il Capo III disciplina il funzionamento del nuovo European Board for Media Services (di seguito, il “Board”), organismo indipendente incaricato di coordinare l’applicazione del MFA (cfr. Sezione 2), favorire la cooperazione tra le autorità nazionali (cfr. sezione 3) e adottare pareri su questioni transfrontaliere (Cfr. Artt. 8-17). In questo capo trova spazio una Sezione 4, al digitale, dove prende forma un micro-regime speciale applicabile alle VLOPs. Tale sezione costituisce il nucleo operativo dell’interazione tra il Media Freedom Act e il Digital Services Act, in particolare:
- L’Articolo 18 impone ai fornitori di VLOP una funzionalità di autodichiarazione per i media che rispettano i requisiti dell’Articolo 6, paragrafo 1, MFA. Quando una VLOP intende sospendere o limitare contenuti di un MSP in base ai propri termini contrattuali, deve motivare e concedere 24 ore affinché l’MSP possa replicare prima di agire; l’obbligo non opera se la piattaforma interviene per contenuti illegali o nell’ambito degli obblighi DSA su rischi sistemici (cfr. Artt. 34-35 DSA), tutela dei minori (cfr. Art. 28 DSA), o dell’Art. 28-ter Direttiva SMAV. Il MFA, inoltre, prioritizza i reclami (cfr. Art. 11 P2B; Art. 20 DSA), prevede ipotesi di mediazione e/o Online Dispute Resolution (“ODR”) (cfr. Art. 12 P2B; Art. 21 DSA), e richiede trasparenza annuale sulle misure adottate verso i media (cfr. Art. 18, paragrafo 8).
- Il meccanismo di cui sopra è rinvigorito dall’Articolo 19 che istituisce un dialogo strutturato e periodico tra VLOPs, fornitori di servizi di media e società civile, coordinato dal Board, con l’obiettivo di monitorare l’applicazione dell’Articolo 18, promuovere la diversità dell’offerta mediatica e garantire il rispetto di codici di condotta e iniziative di autoregolamentazione. Il Comitato riferisce alla Commissione gli esiti di questi tavoli e, ove possibile, li rende pubblici, creando un circuito di accountability che affianca la trasparenza dei report annuali dei VLOP ex Articolo 18, paragrafo 8.
- Completa il quadro l’Articolo 20 che, dall’8 maggio 2027, riconosce agli utenti un diritto alla personalizzazione dell’offerta mediatica su dispositivi e interfacce: i produttori/sviluppatori/importatori avranno obblighi by design di garantire ex ante la modificabilità delle impostazioni predefinite e la visibilità costante dell’identità dei fornitori di servizi di media, a tutela della riconoscibilità editoriale nello spazio digitale.
Il medesimo capo introduce, infine, introduce regole sulla misurazione trasparente dell’audience (cfr. Art. 24) e sulla distribuzione della pubblicità statale secondo criteri non discriminatori (cfr. Art. 25).
- Il Capo IV contiene, in conclusione, le disposizioni finali e transitorie prevedendo meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica, modifiche puntuali alla Direttiva SMAV e scadenze differenziate per l’entrata in applicazione (cfr. Artt. 26-29)
3. Dal Notice and Action al Notice and Comment: un nuovo paradigma qualitativamente rinforzato?
Il raffronto tra l’Articolo 16 del DSA e l’Articolo 18 del MFA mette in luce un’affascinante trasformazione nell’architettura giuridica della moderazione dei contenuti online, segnando il passaggio da un modello reattivo, orientato alla rimozione rapida dei contenuti potenzialmente nocivi, ad uno idealmente dialogico e garantista, centrato sulla tutela del pluralismo e dell’indipendenza editoriale.
- L’Articolo 16 DSA disciplina i meccanismi di notice and action, imponendo ai fornitori di servizi di hosting di predisporre strumenti elettronici chiari, accessibili e intuitivi per consentire a qualsiasi individuo o entità di segnalare la presenza di contenuti ritenuti illegali. La notifica deve essere precisa e adeguatamente motivata, indicare la localizzazione esatta del contenuto (es. l’URL), fornire i dati identificativi del segnalante, salvo eccezioni, e includere una dichiarazione di buona fede. Quando la segnalazione è conforme, essa genera per il provider “conoscenza effettiva” del presunto illecito, attivando l’obbligo di intervenire senza indugio, in modo diligente, obiettivo e non arbitrario. Il DSA richiede inoltre che il segnalante sia informato della ricezione e dell’esito della decisione, con indicazione delle possibili vie di ricorso, e impone trasparenza sull’eventuale impiego di strumenti automatizzati.
- L’Articolo 18 MFA, invece, introduce un regime specifico per i fornitori di servizi di media presenti sulle VLOPs, riconoscendo loro un insieme di garanzie procedurali che si fondano su un principio chiave: il contraddittorio preventivo. Il meccanismo si attiva quando il media provider, previa dichiarazione di conformità a requisiti di indipendenza editoriale, assenza di influenze politiche o statali e rispetto delle norme professionali, subisce una decisione di rimozione, limitazione o sospensione di contenuti. In tal caso, la piattaforma è obbligata a comunicare preventivamente i motivi della decisione e a concedere almeno ventiquattro ore per consentire una replica, valutando le osservazioni ricevute prima di procedere. Questo schema ribalta la logica unilaterale tipica del notice and action, sostituendola con un procedimento scandito, trasparente e partecipato. Nei casi di restrizioni ripetute, la piattaforma deve avviare un dialogo strutturato in buona fede con il fornitore, con la possibilità di coinvolgere il Board istituito dal MFA, e, in mancanza di soluzione, si potrà ricorrere a strumenti di mediazione o a meccanismi extragiudiziali coerenti con il DSA e il Regolamento P2B.
Il rapporto tra i due strumenti non è, dunque, di mera sovrapposizione ma di sinergia funzionale. Il DSA opera come disciplina di base, uniforme e generalista, volta a garantire una risposta rapida e proporzionata contro i contenuti illegali, riducendo i tempi di esposizione e prevenendo danni immediati. Il MFA agisce in un perimetro ben delineato, introducendo un diritto procedurale speciale per i media, che bilancia l’esigenza di intervento tempestivo con la salvaguardia dell’indipendenza editoriale e del pluralismo informativo. Il notice and action resta la spina dorsale dell’enforcement, ma il notice and comment aggiunge una dimensione di dialogo regolato e verificabile, impedendo che decisioni algoritmiche o interventi sommari possano comprimere in modo irreversibile il dibattito democratico.
4. Conclusioni
In definitiva, l’interazione tra MFA e DSA configura un doppio binario regolamentare in cui la rapidità dell’azione e la certezza dell’enforcement trovano un contrappeso nella garanzia procedurale e nel presidio del pluralismo. Laddove il DSA assicura un quadro uniforme e reattivo per il contrasto ai contenuti illeciti, il MFA eleva la moderazione a procedimento giuridicamente qualificato, scandito da preavviso motivato, contraddittorio effettivo e tracciabilità delle decisioni.
Quest’architettura, frutto di un’evoluzione ventennale dalla Good Samaritan clause al notice and comment, riflette un passaggio culturale: dalla mera gestione tecnica dei flussi informativi alla tutela sostanziale dello spazio pubblico digitale come bene comune europeo. In un contesto in cui oltre il 60% degli utenti accede alle notizie tramite piattaforme digitali e diversi Stati membri registrano arretramenti preoccupanti negli indici internazionali di libertà di stampa, la posta in gioco è eminentemente politica e costituzionale e il rischio è che il MFA diventi lettera morta; in sostanza.
La sfida, ora, è trasformare queste previsioni in prassi effettive: garantire che i meccanismi di dialogo strutturato non diventino meri adempimenti formali, che il Board sappia esercitare un ruolo di indirizzo incisivo, e che le VLOPs interiorizzino l’obbligo di cooperazione come elemento strutturale del loro modello di governance. Se attuato con coerenza, il combinato disposto di MFA e DSA può costituire il fondamento di un nuovo equilibrio europeo tra enforcement digitale e salvaguardia delle libertà fondamentali, capace di resistere tanto alle pressioni censorie quanto all’arbitrio algoritmico.
Su di un simile argomento può essere d’interesse l’articolo: Pubblicato il DSA: nuovo regime di responsabilità ISPs.