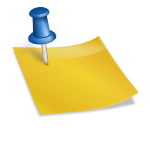Il 25 settembre 2025, nove primari gruppi bancari europei – ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank e Raiffeisen Bank International – hanno annunciato la costituzione di un consorzio per l’emissione di un token di moneta elettronica (di seguito, “EMT” o “stablecoin“) il cui valore risulterà direttamente e stabilmente ancorato all’Euro, in conformità al Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (di seguito, “MiCAR”).
Il lancio, previsto per la seconda metà del 2026, rappresenta la prima iniziativa paneuropea promossa direttamente da istituti di credito, con l’obiettivo di introdurre uno strumento di pagamento digitale regolamentato, sicuro e scalabile, in grado di competere con le iniziative statunitensi e rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione europea nel settore dei pagamenti.
Lo stablecoin sarà emesso attraverso una società con sede nei Paesi Bassi che richiederà l’autorizzazione come Istituto di moneta elettronica (di seguito, “IMEL”) sotto la vigilanza della Banca Centrale Olandese, la De Nederlandsche Bank (di seguito, la “NDB“). In questo modo, il progetto mira a coniugare i requisiti prudenziali e di governance previsti da MiCAR, dalla Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (di seguito, “PSD2”) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (di seguito, “CRR”), con le caratteristiche tipiche delle tecnologie a registro distribuito (di seguito, “DLT”).
L’infrastruttura promessa offre pagamenti istantanei, a basso costo e disponibili 24/7, con potenziali applicazioni che includono i trasferimenti transfrontalieri, il monitoraggio di operazioni in attività digitali e una maggiore tracciabilità delle catene di approvvigionamento.
Rimangono tuttavia delle criticità. La proliferazione di stablecoin sul mercato europeo può rappresentare un’opportunità in termini di concorrenza, ma anche un rischio di frammentazione, amplificato dalla coesistenza di altri strumenti di pagamento digitale come i bonifici istantanei, disciplinati dal Regolamento (UE) 2024/886 (di seguito, “IPR“). Inoltre, anche l’effettiva adozione da parte di consumatori e imprese resta incerta, a causa della scarsa familiarità degli utenti con lo strumento.
Nonostante tali incertezze, l’iniziativa conferma l’orientamento dell’industria bancaria e decentralizzata europea: lo stablecoin è destinato a collocarsi tra i tre principali metodi di pagamento nei prossimi anni, fondando la propria diffusione su velocità, efficienza, trasparenza e tracciabilità.
- Un consorzio bancario europeo tra MiCAR e sovranità digitale
Il progetto promosso da nove primari istituti di credito europei segna una netta discontinuità rispetto alle precedenti esperienze di stablecoin. Non si tratta infatti di un’iniziativa guidata da operatori tecnologici non regolamentati sotto il profilo finanziario ma di uno strumento concepito sin dall’origine entro un quadro normativo vincolante, in linea con MiCAR e PSD2.
La scelta di costituire la società nei Paesi Bassi e di richiedere l’autorizzazione come IMEL sotto la vigilanza della DNB ha una valenza precisa: garantire che il nuovo EMT sia assimilato, sin dalla sua emissione, a uno strumento di pagamento regolamentato, soggetto a requisiti di capitale, governance e tutela della clientela paragonabili a quelli richiesti agli operatori del mercato tradizionale.
Il valore aggiunto del progetto non si esaurisce nell’aspetto tecnico-giuridico. La decisione di nove banche di convergere su uno standard comune mira a rafforzare la sovranità digitale europea, riducendo la dipendenza da stablecoin di matrice extra-UE, in larga parte statunitense.
Si tratta di una risposta complementare, e non alternativa, al progetto dell’euro digitale promosso dalla Banca Centrale Europea (di seguito, la “BCE”): mentre quest’ultimo resta un’iniziativa istituzionale ancora in fase di definizione, lo stablecoin consortile è uno strumento privato pronto ad affermarsi nel breve termine come mezzo di pagamento disciplinato dal diritto dell’Unione.
L’impatto simbolico è altrettanto rilevante: l’adozione di una DLT non è più relegata a progetti sperimentali, ma diventa parte integrante dell’infrastruttura finanziaria europea. In questa prospettiva, lo stablecoin bancario rappresenta il battesimo di fuoco di una fase in cui l’innovazione digitale e la regolamentazione prudenziale si combinano per definire un modello europeo di pagamenti regolamentati.
- Opportunità e rischi
Una tale iniziativa apre interrogativi cruciali sul futuro della concorrenza nei pagamenti digitali.
Per la prima volta, il mercato europeo si troverà a confrontarsi con un mosaico di strumenti e prodotti disciplinati da regole differenti – EMT, bonifici istantanei e in prospettiva l’euro digitale – con il rischio concreto che l’innovazione si traduca in frammentazione anziché in efficienza.
Sul piano competitivo, la presenza di più stablecoin potrebbe stimolare la concorrenza in termini di costi e velocità, ma al tempo stesso creare una nuova forma di segmentazione del mercato, in cui utenti e imprese saranno costretti a scegliere tra circuiti non sempre interoperabili. Questa pluralità di standard rischia di minare proprio l’obiettivo dichiarato del MiCAR: garantire un quadro unitario e armonizzato per gli strumenti digitali.
La competizione con gli instant payments aggiunge un ulteriore livello di complessità. I bonifici istantanei regolamentati da IPR consentono già oggi trasferimenti in tempo reale a livello europeo, senza richiedere l’adozione di nuove tecnologie da parte dell’utente. Perché uno stablecoin bancario diventi davvero competitivo, dovrà quindi offrire qualcosa in più: programmabilità dei pagamenti, automazione dei flussi o soluzioni transfrontaliere non coperte dagli schemi SEPA. In caso contrario, il rischio è che resti confinato a un ambito di nicchia, incapace di scalare.
Il nodo centrale resta l’adozione da parte del pubblico. Nonostante l’attenzione crescente dell’industria, la conoscenza degli stablecoin resta bassa, persino tra gli operatori finanziari più attenti all’innovazione. La recente Comunicazione di Banca d’Italia sugli EMT lo dimostra chiaramente: senza un lavoro di educazione finanziaria e senza la costruzione di fiducia verso nuovi strumenti regolamentati, l’offerta rischia di precedere la domanda. In questo senso, la legittimazione che deriva dal coinvolgimento diretto delle banche può essere decisiva: la fiducia nell’intermediario tradizionale è ciò che può trasformare lo stablecoin da “esperimento tecnologico” a strumento d’uso quotidiano.
L’Europa, quindi, corre il rischio di moltiplicare i circuiti senza rafforzarne la stabilità.
- Requisiti regolamentari e profili applicativi
Il tratto più significativo dello stablecoin bancario europeo non è la tecnologia su cui si fonda, ma il modo in cui viene incardinato nel quadro regolamentare dell’Unione.
L’iniziativa, infatti, non ammette scorciatoie: gli istituti coinvolti, qualora intendano prestare servizi aventi ad oggetto l’EMT, dovranno rispettare in parallelo i requisiti previsti da MiCAR e da PSD2, assumendo così oneri prudenziali e di governance tipici tanto dei prestatori di servizi per le cripto-attività (“CASP”) quanto degli istituti di pagamento (“IP”) e degli IMEL.
Il primo elemento di novità è la cumulatività dei presidi patrimoniali: non sarà possibile scegliere se applicare MiCAR o PSD2, ma occorrerà rispettare entrambi, garantendo fondi propri e coperture assicurative idonee a fronteggiare l’intero spettro di rischi legati alla prestazione di servizi in stablecoin. La stessa logica vale per gli assetti proprietari e per gli esponenti aziendali, sottoposti a requisiti più ampi rispetto a quelli già previsti da MiCAR: onorabilità, correttezza, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo effettivo, secondo la disciplina bancaria tradizionale.
Sul piano operativo, l’attenzione si concentra sulle tutele della clientela.
Dal 2026 i pagamenti in stablecoin bancario dovranno essere protetti da procedure di strong customer authentication (“SCA”) analoghe a quelle applicate ai pagamenti elettronici tradizionali, con responsabilità diretta dell’operatore in caso di mancata applicazione.
A questo si aggiunge l’obbligo di reporting periodico delle frodi, che estende alla prestazione di servizi in EMT la disciplina già prevista per gli strumenti di pagamento classici. È invece confermata l’esclusione delle norme sull’open banking, ritenute incompatibili con la logica delle infrastrutture DLT: un adattamento mirato che evita forzature tecniche senza ridurre il livello di tutela per l’utente.
Il risultato complessivo è un quadro regolamentare in cui lo stablecoin bancario europeo si colloca allo stesso livello di affidabilità e accountability degli strumenti di pagamento convenzionali. Per le banche, ciò implica assumere oneri di compliance e vigilanza rafforzati; per il mercato, significa avere a disposizione un asset digitale che, per la prima volta, coniuga innovazione tecnologica e disciplina prudenziale priva di zone grigie.
In conclusione, uno stablecoin bancario europeo non rappresenterebbe solo un semplice tassello aggiuntivo. Per la prima volta uno strumento digitale entra nel vivo della regolazione finanziaria, con oneri patrimoniali, governance e tutele della clientela assimilabili a quelli dei prestatori tradizionali.
L’UE compie così un passo deciso verso l’autonomia strategica nei pagamenti, bilanciando innovazione e stabilità. Chi saprà arrivare preparato non si limiterà ad adeguarsi alle regole ma potrà guidare la nascita di un nuovo standard europeo nei pagamenti digitali.
Autori: Andrea Pantaleo e Giulio Napolitano