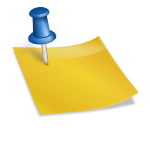Nel 2021, le merci contraffatte hanno rappresentato il 2,3% del commercio globale e quasi il 5% delle importazioni nell’Unione Europea. È questo il dato di apertura, allarmante ma purtroppo non sorprendente, contenuto nell’ultimo rapporto congiunto OCSE-EUIPO “Mapping Global Trade in Fakes 2025” (il “Rapporto”), che fotografa un fenomeno sempre più sofisticato, capillare e resistente ai tradizionali strumenti di enforcement.
Il nuovo volto della contraffazione: produzione “localizzata” e logistica frammentata
Uno dei trend più rilevanti individuati nel Rapporto è la cosiddetta localisation delle attività illecite: la produzione e l’assemblaggio dei prodotti contraffatti avvengono sempre più spesso vicino o all’interno dei mercati di destinazione, talvolta in zone franche, dove i controlli doganali sono meno rigorosi. I contraffattori adottano strategie complesse come l’importazione separata di componenti, etichette e packaging, in modo da ridurre il rischio di intercettazione e aggirare più agevolmente le misure anti-contraffazione.
Parallelamente, l’aumento esponenziale del commercio elettronico e la diffusione delle spedizioni in piccoli pacchi ha spostato il baricentro della logistica del falso: quasi l’80% delle spedizioni sequestrate tra il 2020 e il 2021 conteneva meno di dieci articoli, e quasi il 60% è transitato via posta ordinaria. Si tratta di canali difficilmente controllabili, anche perché le descrizioni dei beni in dogana sono spesso vaghe (“stuff”, “daily necessities”).
I settori più colpiti: non solo moda e lusso
La contraffazione colpisce quasi metà delle categorie merceologiche analizzate nel sistema armonizzato delle dogane. Abbigliamento, calzature, articoli in pelle ed elettronica restano in testa tra le categorie merceologiche più colpite, ma crescono anche i sequestri nei settori della cosmetica, dei giocattoli, delle apparecchiature mediche e, in modo preoccupante, dei ricambi auto e dei prodotti farmaceutici.
Il fenomeno non ha solo implicazioni di carattere economico: gli articoli contraffatti spesso non rispettano standard minimi di sicurezza e possono mettere seriamente a rischio la salute pubblica. Inoltre, sono particolarmente pericolosi i cosiddetti “ricambi “zombie”” per autovetture (ad esempio airbag non funzionanti) e i cosmetici prodotti con sostanze vietate.
Le rotte del falso: un problema globale, ma l’Europa è in prima linea
Secondo i risultati del Rapporto, Cina e Hong Kong continuano a essere le principali fonti di merci contraffatte, seguite da Turchia, Libano e Siria. Ma anche paesi come Bangladesh, Colombia e alcune economie africane si attestano tra le giurisdizioni con maggiore propensione a esportare falsi (GTRIC-e score).
Sul fronte della domanda, l’Unione Europea si è confermata come una delle principali destinazioni. Nel biennio 2020-2021, oltre il 60% del valore dei sequestri globali ha avuto come destinazione finale Stati membri dell’UE, con Germania, Belgio e Francia ai primi posti.
Le risposte normative e i nodi ancora irrisolti
Il contesto normativo è frammentato e spesso inadeguato ad affrontare un fenomeno sempre più digitalizzato e trasnazionale. Sebbene l’Unione Europea abbia introdotto misure specifiche per il contrasto alla contraffazione, come il Regolamento (UE) 608/2013 in materia doganale, e iniziative coordinate tramite l’EUIPO, la repressione rimane fortemente disomogenea tra Stati membri.
Un ulteriore problema risiede nelle priorità che vengono attribuite ad alcune categorie di prodotti nell’ambito della lotta alla contraffazione da parte delle autorità: le risorse sono spesso concentrate su traffici ritenuti più pericolosi (droga, armi, terrorismo), lasciando scoperti interi segmenti del mercato del falso, soprattutto quando si tratta di prodotti apparentemente “non dannosi”.
Prospettive per le imprese: tra tracciabilità, collaborazione e tecnologia
Per le aziende, in particolare quelle titolari di marchi registrati, il rapporto OCSE-EUIPO conferma la necessità di adottare strategie multilivello di contrasto. Tra le più efficaci:
- rafforzare i programmi di monitoraggio online e di brand protection;
- collaborare con gli operatori logistici per identificare anomalie ricorrenti nelle spedizioni;
- investire in tecnologie di tracciabilità (es. codici QR sicuri, blockchain);
- sfruttare gli strumenti offerti dagli osservatori pubblici e dalle autorità doganali per segnalare casi sospetti.
Conclusioni
Il commercio globale di prodotti contraffatti non è un fenomeno marginale: è una minaccia concreta e sistemica alla tutela della proprietà intellettuale, alla sicurezza dei consumatori e alla leale concorrenza sul mercato. Le aziende devono affrontarlo con consapevolezza, dotandosi di strumenti tecnici e giuridici efficaci, ma anche contribuendo alla creazione di un ecosistema normativo più coordinato, agile e proattivo.
Su di un simile argomento può essere interessante l’articolo: L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato il suo report più recente sulla violazione online del copyright nell’UE.