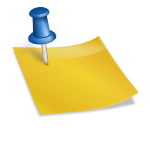Negli ultimi tempi, di fronte agli impegni assunti dalle aziende in tema di sostenibilità e alla sempre maggiore sensibilità dei consumatori soprattutto più giovani, si sono moltiplicate le iniziative legate all’upcycling, dando nuova vita ad articoli delle collezioni precedenti e talvolta modificandoli, anche grazie al successo di piattaforme di reselling quali Vestiaire Collective, Depop o Vinted.
Tale fenomeno ha però sollevato importanti questioni legate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei brand che hanno visto rielaborare e rivendere da terzi i propri prodotti. Sono infatti ormai numerosi i contenziosi promossi da società della moda e del lusso per la rivendita non autorizzata di propri prodotti modificati e, pur in assenza di un orientamento consolidato, è possibile trarre alcune indicazioni rispetto a ciò che è ritenuto consentito e ciò che invece sarà verosimilmente considerato una violazione dei diritti del titolare del marchio.
Tali controversie trovano tutte il proprio fondamento nei diritti esclusivi di marchio e nel principio di esaurimento (o “first sale doctrine” nel diritto americano). Guardando alla normativa nazionale, con la registrazione del marchio vengono riconosciuti in capo al titolare una serie di diritti, tra cui il diritto di utilizzarlo in via esclusiva e di impedirne l’uso a chiunque non sia autorizzato. Tuttavia, in base al principio di esaurimento del marchio, una volta che il titolare mette i beni in commercio non potrà più opporsi ad ulteriori e successive commercializzazioni degli stessi sul mercato. L’art. 5 c.p.i. prevede infatti che “1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo”. Il comma 2 stabilisce però che tale principio non trova applicazione “quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. […]”. In tali casi, infatti, i consumatori potrebbero essere portati a credere che le modifiche apportate al prodotto siano state autorizzate dal titolare del marchio, facendo venir meno la funzione distintiva e di garanzia tipica della privativa in questione.
Per questi motivi, alcuni servizi – quali, ad esempio, i servizi di riparazione o di pulizia di un prodotto – non sollevano particolari complicazioni rispetto all’ambito di applicazione del principio di esaurimento, potendo quindi essere offerti da terzi senza bisogno di ottenere l’autorizzazione del titolare del marchio. Diversamente, quando una terza parte interviene sui prodotti recanti il marchio apportandovi una modifica materiale in modo permanente con lo scopo di rivenderli (ad esempio, cambiandone il calore, aggiungendo applicazioni e dettagli o combinando il capo con elementi di altri brand), l’applicazione del principio di esaurimento è da ritenersi esclusa.
Il principio è stato ribadito in una recente decisione di un tribunale americano nel caso promosso da Rolex nei confronti di una società non affiliata che offriva orologi del brand riparati e modificati con pezzi di ricambio originali e non. In sede di appello il tribunale ha condiviso la tesi di Rolex secondo cui la corte distrettuale in prima istanza aveva sbagliato a vietare soltanto la vendita di orologi in cui il quadrante veniva privato della vernice/rivestimento e delle marcature originali, poi ridipinto/rivestito o a cui erano state aggiunte altre parole, ma non anche la vendita di orologi personalizzati che non comportano la rimozione o la riapplicazione dei marchi di fabbrica di Rolex, e che possono avere aggiunto diamanti, pietre o altri abbellimenti. Il Quinto Circuito ha infatti affermato che “c’è una differenza tra l’aggiunta di diamanti a un quadrante e la rifinitura di un quadrante – la prima è personalizzazione [e] la seconda è restauro“. Il tribunale americano ha dunque sostenuto che il processo di restauro/raffinamento del rivenditore richiedeva necessariamente di rimuovere e riapplicare i marchi di Rolex, mentre non vi era alcuna prova che ciò fosse richiesto anche dal processo di personalizzazione. Pertanto, con l’aggiunta di un disclaimer idoneo ad informare chiaramente i consumatori che la customizzazione non era un servizio offerto da Rolex, al rivenditore è stato consentito di personalizzare gli orologi per i clienti su richiesta.
In un altro caso analogo promosso in Svizzera sempre dalla celebre maison, il Tribunale Federale ha fatto un passo ulteriore, chiarendo espressamente che l’offerta di servizi di personalizzazione da parte di soggetti non affiliati al brand è legale nella misura in cui tali servizi sono disponibili soltanto su orologi forniti da clienti per un uso privato e non destinati alla rivendita. Si tratta di uno dei primi casi in cui viene delineata una linea di demarcazione precisa e il principio è applicabile ad altri settori, come il tuning delle automobili o la trasformazione di abiti di alta moda.
Altra questione è quella legata alle modalità di comunicazione adottate dai rivenditori, in quanto anche queste possono essere idonee a generare un rischio di confusione nel consumatore inducendolo a ritenere che esista un’affiliazione tra le due società.
Infatti, in un’altra annosa vertenza promossa da Chanel oltreoceano contro un noto rivenditore di borse e accessori vintage per violazione di marchio, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, in queste settimane la giuria si è schierata dalla parte della celebre maison francese riconoscendole 4 milioni di dollari a titolo di risarcimento. A tal fine, è stato infatti ritenuto che l’uso ripetuto e non necessario dei famosi marchi di Chanel sul suo sito web e sui suoi profili social media, la pubblicazione di immagini e contenuti esclusivamente associati a Chanel e la rivendita di prodotti, come i copri fazzoletti e gli specchietti a marchio Chanel – che non sono autorizzati alla vendita al pubblico – dimostrassero un tentativo di agganciamento all’immagine e alla reputazione del brand e fossero idonei ad indurre in inganno i consumatori.
Pertanto, tale decisione suggerisce che i rivenditori dovranno prestare molta attenzione al modo in cui commercializzano anche i prodotti autentici, compreso l’uso dei nomi, dei loghi e di altre indicazioni relative al brand, nonché il linguaggio che viene utilizzato nelle dichiarazioni/garanzie sull’autenticità del prodotto. Infatti, è possibile concludere che in tali circostanze il fair use nominativo non li metterà al riparo da responsabilità nel caso in cui facciano un uso eccessivo del marchio altrui e, di conseguenza, implichino falsamente un collegamento tra i rivenditori e i marchi di cui offrono i prodotti.
Su un argomento simile si veda l’articolo ” Upcycling: moda sostenibile e tutela del marchio (dirittoaldigitale.com)“.