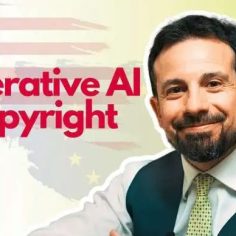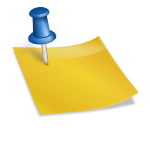Il 18 marzo 2025, la Corte d’Appello del Circuito del Distretto di Columbia ha confermato le precedenti decisioni che negavano la protezione del copyright all’opera “A Recent Entrance to Paradise“, realizzata – secondo quanto sostenuto – esclusivamente dalla “Creativity Machine“, un sistema di intelligenza artificiale ideato dal Dr. Stephen Thaler.
La vicenda ha origine nel 2019, quando Thaler ha presentato domanda di registrazione presso l’Ufficio Copyright degli Stati Uniti, indicando la Creativity Machine come unico autore e sé stesso come titolare dei diritti. L’Ufficio ha respinto l’istanza, e tale decisione è stata successivamente confermata dal Review Board e dal Tribunale Distrettuale del Distretto di Columbia.
Nel corso del procedimento, Thaler ha sostenuto che, in base alla work-for-hire doctrine, il copyright dell’opera sarebbe dovuto spettare a lui. Ha inoltre argomentato che l’opera avrebbe comunque dovuto essere protetta, in quanto realizzata su sua indicazione e sotto la sua direzione.
Con la decisione più recente, la Corte d’Appello ha ribadito che la normativa sul copyright statunitense (Copyright Act of 1976) richiede che ogni opera protetta sia creata da un essere umano. Sebbene la legge non definisca espressamente il concetto di “autore”, l’interpretazione consolidata attribuisce tale status esclusivamente alle persone fisiche.
Pur riconoscendo che in passato alcuni soggetti legalmente riconosciuti come autori non soddisfacevano tutti questi criteri, la Corte ha ritenuto che un’IA non possa in alcun caso possedere capacità giuridica e tantomeno un’intenzionalità creativa.
Il ruolo dell’IA nella creazione di opere protette
Un aspetto chiave della sentenza è la precisazione secondo cui il requisito dell’autorialità umana non esclude la protezione delle opere realizzate con il supporto dell’IA. Se un essere umano utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale per sviluppare un’opera, il risultato può ottenere protezione, a condizione che vi sia un adeguato livello di intervento umano. Il problema, nel caso di Thaler, è che la Creativity Machine era stata indicata come unico autore dell’opera.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui il requisito dell’autorialità umana scoraggerebbe la creatività da parte di chi sviluppa o utilizza l’IA.
Il dibattito sull’autorialità nell’era dell’Intelligenza Artificiale
Secondo molti, questa decisione non sorprende e, al contrario, appare coerente con l’impostazione consolidata sul tema. Il vero limite della vicenda sollevata da Thaler non sta tanto nel rigetto della sua richiesta, quanto nel fatto che il suo caso, a distanza di anni, ha perso rilevanza nel dibattito attuale.
Due sono i motivi principali: da un lato, l’aver indicato la Creativity Machine come unico autore dell’opera; dall’altro, il fatto che alcune delle argomentazioni avanzate – tra cui la presunta incostituzionalità del requisito di autorialità umana e l’idea che Thaler stesso potesse essere riconosciuto come autore – non siano state ulteriormente sviluppate.
Infatti, la domanda attualmente da porsi, non è tanto “chi” può essere considerato “autore”, ma piuttostosto “cosa” rende un autore tale. Occorre dunque domandarsi fino a che punto si possa integrare l’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione di un’opera senza perdere lo status di autore.
Negli Stati Uniti, il recente Second Report on Copyright and Artificial Intelligence del Copyright Office ha chiarito che l’uso di strumenti di intelligenza artificiale non esclude la protezione dell’opera, purché vi sia un controllo umano significativo sugli elementi espressivi. Questo principio, in realtà, non rappresenta un cambiamento di rotta, ma si inserisce in linea di continuità con quanto già stabilito nel Compendium of U.S. Copyright Office Practices e nel 1965 Report to the Librarian of Congress, secondo cui non possono essere registrate opere generate esclusivamente da processi meccanici o casuali, privi di qualsiasi intervento creativo da parte di un autore umano.
In Europa la situazione non è molto diversa. I principi di diritto statunitense si riflettono in larga misura anche nel contesto giuridico europeo. Da tempo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che un’opera è protetta solo se riflette la “personalità” dell’autore e se è il frutto di “scelte libere e creative”. Anche nel quadro normativo UE, quindi, nulla vieta l’uso dell’AI come strumento di supporto alla creazione, ma la protezione riguarda esclusivamente le parti dell’opera in cui il contributo umano è chiaramente riconoscibile.
In definitiva, il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito creativo è tutt’altro che concluso. Se ormai sembra assodato che solo un essere umano possa essere riconosciuto come autore, resta ancora da chiarire in che misura l’intervento umano debba essere presente affinché un’opera possa ottenere protezione. Ed è proprio questa la vera questione, ben più ampia e complessa, che il diritto d’autore dovrà affrontare nei prossimi anni.
Per ulteriori informazioni sulle questioni legali relative all’intelligenza artificiale, consigliamo di leggere la nostra rivista giuridica sull’AI, le cui ultime edizioni sono disponibili QUI.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: Le opere dell’intelligenza artificiale proteggibili per il diritto d’autore?