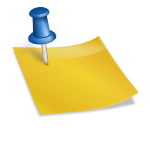La Corte d’Appello di Roma si è recentemente espressa in materia di plagio di opera cinematografica, ribandendo alcuni importanti principi sul concetto di elaborazione creativa.
Il primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2017, una società cinematografica aveva citato in giudizio un’importante emittente televisiva, accusandola di plagio di un film-documentario sulla vita di Felicia Impastato e chiedendo un risarcimento di € 200.000,00. Secondo la società attrice, nella fiction prodotta dalla convenuta si coglieva una esatta riproposizione, qualificabile come vera e propria copiatura, di numerose scene precedentemente realizzate dall’autore e regista incaricato dalla società attrice, nonché la piena usurpazione di altre scene. La difesa della convenuta aveva sottolineato che le due opere, pur avendo lo stesso soggetto, differivano per natura, struttura e modalità narrative, e che gli episodi rappresentati erano di dominio pubblico e non soggetti a monopolio.
Il Tribunale, per valutare la questione, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, che concludeva non sussistere un plagio integrale, ma ipotizzava un plagio parziale. Tuttavia, il Collegio, dopo aver esaminato la consulenza e confrontato le scene, aveva ritenuto le argomentazioni insufficienti e contraddittorie, ribadendo il principio secondo il quale in relazione alla rappresentazione di fatti storici e/o biografici, qualora due opere a confronto hanno la stessa matrice storica e si riferiscono a fatti realmente avvenuti, la tutela autorale non attiene al contenuto, ma solo al modo in cui l’accadimento è trattato. Di conseguenza, aveva escluso la sussistenza di plagio e respinto la domanda della società attrice.
La decisione della Corte d’appello
La sentenza di primo grado è stata impugnata parte attrice, soccombente in primo grado.
In particolare, questa sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente condiviso la conclusione del consulente tecnico d’ufficio (CTU) secondo cui vi sarebbero state differenze strutturali tra le due opere (la narrazione del documentario era definita come “lineare” e quella della fiction come “circolare” con l’uso di flashback). Secondo l’appellante, a nulla rileverebbe tale diversità strutturale, visto che la legge sul diritto d’autore riconoscerebbe l’esistenza del plagio non solo e non tanto quanto all’aspetto strutturale delle opere a confronto, ma quanto alla originalità creativa ed alla novità sotto un profilo qualitativo.
La Corte sul punto ha affermato che il tribunale ha correttamente preso in considerazione la diversità di struttura delle opere, ciò che ha di fatto consentito di valutare anche le singole scene contestate come collocate nei vari contesti. Ha evidenziato, poi, che “è pacifico che in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi al contrario, alla personale ed individuale espressione di una oggettività (…) sicchè un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in esso (come non avvenuto nella fattispecie in esame), un atto creativo, pur se minimo, che sia comunque manifestazione nel mondo esteriore”.
Ancora, la Corte ha ribadito, come supportato da costante giurisprudenza, che “la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono e possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione”.
In altri termini, l’elaborazione creativa, in base alla quale occorre verificare se le singole scene oggetto del presente giudizio possano dirsi creative e, dunque, oggetto di tutela, deve essere individuata in un riconoscibile apporto creativo da valutarsi nel merito in punto di fatto.
Sulla base di detti presupposti, a dire della Corte la valutazione operata dal Tribunale è stata effettuata in maniera esaustiva, anche consentendo al CTU di esaminare le opere nella loro interezza.
Infine, la Corte ha puntualizzato che “nel caso di opere biografiche di personaggi noti, appartengono al patrimonio comune i fatti e le vicende che li hanno riguardati che non sono, in sé, autonomamente monopolizzabili. La tutela autoriale cade, invece, sulle scelte formali, sulle tecniche stilistiche e redazionali, attraverso i quali l’autore li veicola”. Di conseguenza, le scene oggetto di contestazione si presentano, secondo la Corte, non solo come diversamente organizzate nelle due opere, ma anche collocate in opere strutturalmente diverse e, inoltre, rappresentano fatti oggettivamente verificatisi e, dunque, non monopolizzabili.
Conclusioni e prova del plagio
In conclusione, la prova del plagio richiede di dimostrare una rilevante somiglianza nelle scelte stilistiche e nelle tecniche espressive tra le opere: in altri termini, nel punto di vista dell’autore. Questo risulta particolarmente difficile nel caso di biopic o opere che si basano su eventi reali, poiché i fatti storici e le storie di personaggi pubblici fanno parte del patrimonio comune e non sono soggetti a esclusiva.
Su un argomento simile può essere di interesse l’articolo “Progetto, opera architettonica e diritto d’autore: quando sussiste il requisito della creatività?“